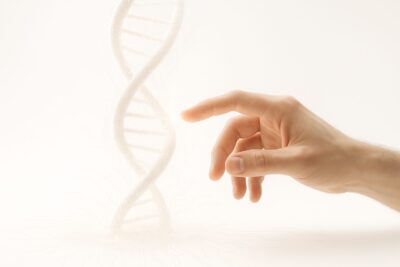Quando penso all’intelligenza artificiale e all’analfabetismo funzionale, vedo subito davanti agli occhi un’immagine che racconta il nostro tempo meglio di qualsiasi saggio: due persone nella stessa stanza, una che scorre dati su un tablet e dialoga con una AI, l’altra che fissa il monitor senza davvero capire cosa gli succede intorno. È un abisso silenzioso che si allarga sotto i nostri piedi ogni giorno, e riguarda tutti: non solo chi “non sa usare il computer”, ma anche chi, pur sapendo leggere e scrivere, rischia di non comprendere più il mondo che cambia. L’ho visto con i miei occhi, decine di volte, e ogni volta mi sono chiesto: siamo davvero pronti per il futuro che abbiamo innescato?
Crisi della comprensione e Valéry
Un secolo fa Paul Valéry scriveva: “Preoccupiamoci innanzitutto di sapere se l’uomo diventa più sciocco, più ingenuo, più debole intellettualmente quando vi è una crisi della comprensione o dell’invenzione.” Questa frase mi rimbalza in testa ogni volta che osservo la velocità con cui l’umanità genera progresso – e l’inquietudine che ne deriva. Sì, perché c’è una crisi nascosta nella società digitale: non sempre capiamo ciò che creiamo. La differenza, rispetto a cent’anni fa, è che la velocità del cambiamento ha accelerato tutto. Oggi, l’intelligenza artificiale ci offre risultati impressionanti, ma spesso ci obbliga a delegare proprio quelle funzioni che, una volta, erano il cuore della nostra individualità e della nostra vita sociale. Rifletto spesso su questa ambivalenza: da un lato siamo più potenti, dall’altro rischiamo di essere meno presenti – più spettatori che protagonisti del futuro.
Ho avuto la fortuna di vedere, nel tempo, tecnologie inimmaginabili nascere e diventare parte della nostra quotidianità. Nel 1994, mentre il mondo iniziava a scoprire Internet, avevo già intuito che il vero rischio sarebbe stato quello di una crisi dell’intelligenza: non capire più il progresso, non riuscire più a giudicarlo, nemmeno a “sentirlo”. Ecco perché ogni volta che vedo una nuova tecnologia – che sia una nuova AI, un esoscheletro, o un computer quantistico che promette di riscrivere tutto (come in questo caso) – mi chiedo: chi, davvero, riuscirà a usarla per crescere, e chi invece rischierà di perdersi ancora di più?
L’impatto concreto dell’intelligenza artificiale
L’innovazione tecnologica nel campo dell’intelligenza artificiale non è più una “profezia” – è già realtà. Le AI generative sono diventate strumenti quotidiani, e la nostra reazione è un misto di meraviglia e inquietudine. Tutto accade molto in fretta: un giorno chiediamo a una AI di risolverci la giornata, il giorno dopo ci affidiamo a lei anche per capire il senso delle cose. È un cambio di paradigma che trasforma l’identità umana. Ho visto la paura negli occhi di molti, ma ho visto anche la forza di chi è riuscito a usare questi strumenti per migliorare la propria vita, come successo nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale come governance.

Le differenze di approccio sono enormi e spesso nascoste. C’è chi vive la digitalizzazione come una liberazione, chi come una minaccia. Ho incontrato imprenditori che hanno cambiato tutto grazie alla potenza dei dati, e altri che hanno perso la bussola di fronte a una dashboard incomprensibile. Le AI sono il riflesso delle nostre forze e debolezze: ci rispecchiano, a volte ci superano, e quando non capiamo, ci lasciano più soli. In questa tempesta, la vera bussola sono le nostre competenze – e qui si apre una questione cruciale: chi decide cosa conta davvero come “competenza” nel mondo del futuro?
Fiducia, competenze e culture a confronto
L’ultimo decennio ha acceso un faro sulle differenze culturali che modellano il nostro rapporto con la tecnologia. Uno studio dell’Università di Aachen mette a confronto Germania e Cina: i tedeschi vivono l’intelligenza artificiale con sospetto, attenti alla privacy e all’autonomia; i cinesi, invece, sono più fiduciosi, soprattutto riguardo il progresso sociale che la AI può portare. Questo non è solo un fatto di “carattere nazionale”. È una questione di competenze, di educazione, di fiducia in se stessi e nel sistema. I dati PISA ce lo confermano: dove le competenze scientifiche sono alte, cresce la fiducia nella propria capacità di governare il futuro.
Mi sono spesso chiesto quanto sia vero che la cultura della “tutela dei diritti” incida sulla nostra visione del progresso. Forse, però, conta anche la nostra capacità di comprendere davvero ciò che abbiamo in mano. Perché un’AI è un’arma a doppio taglio: può liberare, può ingabbiare. A volte ci sentiamo semplici spettatori di una rivoluzione, altre volte – come accade tra chi usa davvero strumenti come ChatGPT – abbiamo la sensazione di poter cambiare il gioco, almeno un po’. La differenza la fa la competenza. La vera domanda oggi è: chi possiede le chiavi del futuro digitale?
PIAAC, PISA e la realtà italiana
Secondo l’OCSE, in Italia una persona su tre tra i 16 e i 65 anni non riesce a comprendere ciò che legge o a risolvere problemi di base. Parliamo di analfabetismo funzionale: persone che sanno leggere e scrivere, ma non riescono a usare le informazioni che ricevono. Qui il futuro rischia di bloccarsi. L’UNESCO definisce questa condizione come l’incapacità di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per partecipare attivamente alla società. Quante volte hai visto qualcuno “saper usare il telefono” ma non saper distinguere una notizia vera da una fake news (questo articolo lo spiega bene)?

Eppure, anche tra gli universitari, i dati sono allarmanti: l’89% usa strumenti di AI per studiare, ma solo il 32% si ritiene capace di gestirli. Gli altri si affidano ciecamente. Questo non è solo un problema di scuola o di università. È la spia di una società che rischia di delegare troppo – e troppo in fretta – le proprie decisioni, i propri pensieri, a “macchine” che sembrano saperne più di noi.
Effetti cognitivi: esperimenti, studenti e memoria
Il MIT Media Lab ha lanciato un esperimento dirompente: tre gruppi di studenti, una prova scritta, ChatGPT sullo sfondo. I risultati? Chi non ha usato la AI ha mostrato maggiore attività cerebrale e migliore memoria a lungo termine. Ho letto questi dati e mi sono chiesto: quanto stiamo davvero imparando, e quanto stiamo solo “scaricando” il lavoro sulle macchine? È la stessa sensazione che provi quando usi un navigatore GPS per anni e poi ti perdi nella tua stessa città. L’intelligenza artificiale potenzia tutto, ma rischia di atrofizzare proprio ciò che ci rende umani: il pensiero critico, la creatività, la memoria.
Mi ricordo la prima volta che un mio amico ha chiesto ad Alexa di “trovare la risposta” invece di pensarci da solo. Da allora, quella scena si è moltiplicata a dismisura. E non riguarda solo la tecnologia: è il nostro modo di intendere la conoscenza che sta cambiando. Se usata bene, la AI è uno strumento che amplifica il potenziale umano, come già visto nel caso della ricerca genetica; se usata male, ci rende più fragili, più esposti a convinzioni sbagliate, a bias, all’effetto Dunning-Kruger.
Digitalizzazione e nuove disuguaglianze
La digitalizzazione dei servizi – dal pagamento delle bollette alle prenotazioni sanitarie – è diventata la nuova frontiera della divisione sociale. Chi ha competenze digitali naviga, chi non le ha resta bloccato, si isola. Un esempio vivido: la digitalizzazione delle PA ha aiutato milioni di italiani, ma ha lasciato indietro gli anziani, chi non parla la lingua dei nuovi strumenti, chi si sente “inadeguato” davanti a una schermata che non perdona errori. E così la disuguaglianza si amplifica, come nel caso della crescita delle disuguaglianze analizzata dai dati mondiali.

Il dato DESI ci ricorda che siamo solo al diciannovesimo posto in Europa per competenze digitali. Appena il 42% degli italiani possiede competenze di base, contro una media europea del 56%. È poco, troppo poco. Eppure, questa forbice non è destino: è una scelta. Possiamo colmarla. Come? Facendo crescere una cultura delle competenze che non sia solo “tecnica”, ma anche umana, critica, relazionale. Solo così potremo usare la AI senza esserne usati.
Previsioni e scenari sul futuro delle competenze
Qui si apre il vero viaggio nel futuro. Se l’analfabetismo funzionale resta il grande ostacolo, la partita si gioca su due fronti: competenze “hard” (linguistiche, logiche, digitali) e competenze “life skills” – cioè quelle abilità trasversali che permettono di affrontare la vita, risolvere problemi, gestire le emozioni, prendere decisioni consapevoli. L’OMS lo dice chiaro da trent’anni: la scuola non deve solo valutare, ma aiutare a sviluppare la coscienza dei problemi, non solo la conoscenza.
Oggi, con la forza computazionale delle AI, la posta in gioco è la stessa di sempre: chi saprà adattarsi, chi saprà imparare davvero, chi saprà mantenere il controllo sul proprio percorso? Il mito di Prometeo che si ribalta: l’uomo crea una macchina che rischia di superarlo, ma solo se si dimentica di essere umano, sociale, parte attiva di una comunità. In fondo, la vera immortalità umana non è vivere per sempre, ma lasciare tracce di cambiamento reale nella società che abitiamo.
Il futuro? Secondo me, e qui la previsione è di quelle che lasciano il segno, nei prossimi dieci anni assisteremo a una doppia accelerazione: chi investirà sulle competenze sarà protagonista, chi resterà fermo rischierà di essere travolto. Le AI continueranno a migliorarsi, ma sarà la capacità di imparare e di imparare a imparare che farà la differenza tra chi guida e chi segue. Mi aspetto una scuola nuova, dove si insegna a usare l’AI non per “barare” ma per creare, dove la cultura digitale va di pari passo con quella umanistica, dove la curiosità è più importante del voto.

Chiudo con una domanda: sei pronto a diventare parte attiva di questo cambiamento? FuturVibe non è solo il mio viaggio, ma quello di tutti quelli che, anche per un attimo, vogliono sentirsi protagonisti del futuro. E qui la scelta non è aspettare che arrivi il nuovo, ma farlo accadere – insieme, competenti e curiosi.
Vuoi far parte della community che davvero cambia il futuro? Diventa socio di FuturVibe e porta la tua energia in un gruppo di visionari che si aiutano, si ascoltano e costruiscono. Ogni iscritto è una nuova possibilità per tutti. Associati ora!
FuturVibe ha scritto questo articolo verificando tutte le seguenti fonti: OCSE (rapporto PIAAC 2024), UNESCO, MIT Media Lab, DESI (indice digitale europeo), OMS, Università di Aachen, dati PISA, Bollettino OMS Skills for Life, Paul Valéry “Sur la crise de l’Intelligence”, esperienze e visioni di Everen, report di FuturVibe.